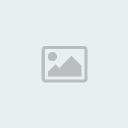
“Il posto dove ci troviamo, il fatto di essere qua con te a fare questa chiacchierata e a toccare un certo tipo di argomenti e non altro: tutto questo ha una sua ragion d’essere, non è casuale. Perché nulla è casuale, se ci pensi bene. Gli incontri che fai, quando li fai, il modo in cui si svolgono… quello che ti succede attorno… Sei tu che forzi gli eventi, in realtà, e fai in modo prendano una certa piega: lo fai con le tue scelte, le tue passioni, le tue pulsioni, le tue paranoie. Perché quello che hai dentro lo riversi all’esterno. Influenzando non solo il tuo comportamento, ma anche il modo in cui gli altri si comportano con te”. Non sono mai banali, le chiacchierate con Claudio Coccoluto. Non sono mai banali, perché Claudio è un uomo che rifletto molto. Soprattutto, è un uomo che è capace di fare autocritica. Cosa rarissima. La nostra chiacchierata – lunga, ma preziosa riga per riga – si è chiusa con l’ammissione “Dal 2005 al 2008, più o meno, ho galleggiato. Sì, hai capito bene: artisticamente parlando, ho vivacchiato. La minimal regnava e io provavo a capirla, non capendola. La suonavo, pur non sentendolola mia. Lo facevo perché ero troppo attaccato al mio lavoro, ero insomma diventato vittima di alcuni dei meccanismi che esso comporta. Mi ha salvato il programma in radio, su Deejay: per farlo ho dovuto riprendere ad ascoltare veramente i dischi, visto che dovevo fare una selezione molto accurata. Lì ho ripreso contatto con quella che è la passione vera, finalmente”. Pochi, pochissimi altri artisti sarebbero in grado di fare un’ammissione così sincera. Ma Coccoluto è di un’altra pasta. Interviste come questa, su Soundwall come altrove, non ne leggerete molte.
C’è poco da fare, Claudio, si torna sempre a parlare di ciò che più ha contrassegnato la tua immagine pubblica: il momento di gigantesco successo negli anni ’90…
Eh, se in quel momento di esplosione commerciale avessi agito diversamente, con tutti i mezzi che avevo a mia disposizione, ora magari sia io che altre persone si troverebbero in una situazione diversa. Sai, mi dicono spesso “Ma perché tu non hai fatto come Sven, perché tu e gli altri italiani famosi non avete creato delle strutture a livello europeo”. Sai che c’è? Io ho provato a farlo. Ma evidentemente non avevo la preparazione… Che dirti, mi sa che è proprio vero che l’artista italiano è impreparato alla dimensione imprenditoriale d’azienda, proprio culturalmente. La cultura artistica non ci manca, tutt’altro, è la cultura aziendale che evidentemente non ci entra in testa. Io c’ho provato, e c’ho provato evidentemente dal verso sbagliato: mi sono buttato sul club, pensando al club come il vero principale motore di tutto il movimento. Solo che nel farlo mi limitavo a vederlo, il movimento, come un insieme di tre soli elementi: il club, il dj, il pubblico. Tutto il resto mi era secondario, praticamente irrilevante. Non ho mai preso seriamente in considerazioni altri aspetti come produzione, marketing…
…il concetto di brand…
Bravo. Fammi dire che il concetto di brand, per come è sviluppato oggi, è pericolosissimo. Un tempo c’era la discografia, c’erano le label che facevano cartello fra di loro, e non era bello, no; ma oggi questo concetto di “brand” è ancora più onnicomprensivo, perché non mette in campo solo un’entità discografica ma varie entità in tutti i campi, e il suo potere ancora più assoluto: se ci sei dentro sei salvo, se invece non appartieni ad alcun brand sei in un nulla cosmico. Ma proprio questo però dovrebbe portarci a prendere una posizione sana, intelligente, se vogliamo essere lucidi.
Quale?
Rimettere al centro di tutto il dj. Il dj, ovvero quello che fa ballare e stare bene la gente. Lui. Fine. Vedi, quando io ad un certo punto mi sono guardato indietro, riflettendo su quello che avevo fatto e quello che avrei dovuto iniziare a fare, mi sono detto: io voglio essere un dj. Non un produttore. O meglio: voglio essere prima di tutto un dj, che ogni tanto si diverte a produrre, ecco. Ma la mia anima, la mia vera personalità e predisposizione artistica è quella del dj. Io esisto in quanto “mettitore di dischi”. Questa è la mia arte, “arte” nel senso che io mi sento semplicemente un artigiano. La sottolineo questa parola: artigiano. Se invece cominciamo a parlare di brand, di marketing, di industria… No, non lo sopporto, inutile che lo neghi, è proprio una cosa che non fa per me. Perché io sono convinto che la comunicazione avvenga tra persone, è tra persone che nascono le vere connessioni vitali, quelle che creano un’energia sincera e profonda; se invece basi tutti sul marketing, sulla brandizzazione, succede esattamente quello che sta succedendo da anni a questa parte: fenomeni che durano lo spazio di una stagione, spesso nemmeno quella; dischi ed artisti che non lasciano nulla, non si sedimentano. Non sono tutti così, ovvio, ma quelli che non lo sono pochi, pochissimi, se pensiamo alla mole immane di musica che esce nella scena elettronica oggi.
In effetti un tempo il “traffico” di uscite ed artisti sembrava un po’ meno caotico, adesso invece in certi momenti pare quasi di vedere gli effetti di una catena di montaggio che funziona a pieno regime.
L’impressione è che si spari a raffica pensando più o meno “Beh, prima o poi il bersaglio lo colgo”. Ok, non è un discorso che vale per tutti, ma è un dato di fatto che un tempo per affacciarsi nel mercato discografico c’era tutto un preciso percorso – fatto di studi di registrazioni, di tecnici del suono, di masterizzazioni di un certo livello e solo in determinati luoghi – che non potevi bypassare. Questo significa che era obbligatorio confrontarsi tanto con le persone quanto con se stessi: perché da un lato avevi a che fare anche con altri, gente che erano professionisti magari di livello superiore, e perché dall’altro comunque tutto questo processo richiedeva tempo e molti soldi, quindi tu non ti potevi permettere di agire con superficialità. Sai, l’altra sera, ho buttato già una traccia che mi piace molto: l’ho fatto in venti minuti netti. Venti minuti! Prima ho pensato “Wow, per creare una traccia fatta e finita qundici anni fa c’avrei messo tre giorni!”; il pensiero seguente però è diventato “…ma quindici anni fa, questa stessa traccia mi sarebbe piaciuta? Mi avrebbe soddisfatto?”. Ecco. La modificazione del gusto personale e della percezione del proprio agire in atto con lo sviluppo delle tecnologie è una discussione da tenere sempre aggiornata, sempre. Dobbiamo capire cosa cappero stiamo facendo. Questo è il punto. Questa è la mia battaglia. Alla soglie dei cinquant’anni, non me ne può importare di meno di fare la competizione sul terreno della visibilità, della fama.
Beh sai, facile detto da uno che era la fama e la visibilità per eccellenza…
Sì, ma non lo volevo. O meglio, diciamo che non avevo iniziato a fare il dj con quell’obiettivo lì. Pensa a Cristoforo Colombo (e ovviamente non è che voglia paragonarmi a lui come grandezza, è per capirci): quando salpò con le sue Caravelle sono convinto che sì, pensava alla gloria e anche ai soldi, ma non pensava che avrebbe scoperto l’America e cambiato la storia dell’umanità. O uno come Steve Jobs: quando si è messo a fare quello che faceva, lo faceva per amore dell’invenzione, del migliorare se stesso, non per diventare l’imprenditore più famoso e ricco del pianeta. Tu fai le tue cose; le fai bene; cerchi di farle il meglio possibile, col massimo dell’accuratezza e della dedizione; e lì è possibile che ad un certo punto ti accadono cose clamorose che non avevi minimamente messo in conto… La visibilità enorme che ad un certo punto mi sono ritrovato ad avere (perché è vero, l’ho avuta) non è una cosa che ho rincorso. Mi è capitata. E quando è capitata, ero come un bambino che, in un Luna Park, trovava per terra un blocchetto con una serie di biglietti omaggio per salire sulla giostra. Nel mio caso, è stata la giostra della televisione, dei media, di tutto ciò che andava oltre la singola serata nelle discoteche. Io, che sono una persona curiosa, su questa giostra ho voluto salirci, mi piace entrare in contesti diversi per poterli conoscere meglio, più da vicino.
Perfino a Sanremo sei andato, come giurato.
Esatto. E non l’ho fatto per visibilità personale, credimi: dicendo di sì a quella proposta, la mia intenzione era di aiutare la categoria tutta dei dj, facendo vedere che aveva tutta la dignità per stare in un contesto come quello. Non l’ho fatto per vantaggio personale. Anzi, guardiamo ai fatti: per me personalmente quella partecipazione lì è stata più uno svantaggio che il suo contrario… perché sono diventato più conosciuto nel mainstream, sì, ma di questo non me ne poteva fregare niente; nell’unico contesto che invece mi interessava, quello della club culture, ho cominciato ad essere visto con crescente sospetto, i malintesi si sono moltiplicati… lì scopri che spesso e volentieri è proprio il cosiddetto underground ad essere ben più spocchioso e stereotipato del mondo pop, del mainstream.
Oggi non c’è più bisogno di cercare visibilità mainstream per la club culture, o almeno ce n’è molto ma molto di meno.
Grazie al web, le opzioni di visibilità si sono moltiplicate a dismisura, e questo è un bene. Peccato che siano facilmente opzioni che durano lo spazio di un mattino, e quelle realmente di qualità sono pochissime, forse ancora meno di quelle che c’erano prima. Vedo che molti miei giovani colleghi passano mattinate intere sui social network: ecco, ora la traccia la puoi fare in soli venti minuti e non in tre giorni, e questa è una benedizione, così come è una benedizione il fatto che tu possa cavartela da solo spendendo pochi soldi e senza dover andare in studi di registrazione dove magari hai a che fare con tecnici che ti dicono sprezzanti “Questa cassa è in controfase”, perché non capiscono nulla della musica che fai. Tutto questo è ottimo, davvero. Ma se il tempo e l’energia che guadagni lì li usi poi tutti per per non confrontarti con la realtà… Visto che sì, stare sui social non è confrontarsi con la realtà, chiaro? Lo vogliamo dire? Utilissimi i social network, decisivi, come no. Mi ricordo quando nel 2000, ad Ibiza, Sven Väth mi diceva convinto “No cappero, guarda che stare su MySpace è assolutamente necessario” e io manco sapevo che diavolo fosse ‘sto MySpace (vedi quanto ragionano in modo più efficace dal punto di vista del business i tedeschi? Capisci perché partono avvantaggiati?). Bene, benissimo.
…ma?
Ma, impieghi il tuo tempo a fare networking sui social poi però ti dici “Oddio, in questa mezza giornata spesa davanti al monitor potevo magari fare altre due tracce, o meglio ancora incontrare di persona degli amici, delle persone che stimo e che mi danno stimoli veri”. Parlare faccia a faccia fa la differenza. In tal senso, per me Skype è molto meglio di Facebook: almeno vedi in faccia la persona con cui parli. E’ già qualcosa, anche se non è il massimo. Però ecco, tornando al punto: passare il tempo sui social io la vedo come una perdita di tempo, o almeno come qualcosa di non essenziale per quelle che io sento come mie esigenze. Io sento di avere ancora tantissime cose da dire, come artista e come persona, e le voglio dire. Di tempo non ne voglio più perdere. Voglio continuare a fare quello che so fare veramente e quello che sento veramente, e questa cosa è mettere dischi. Tra l’altro, proprio questo ragionamento è quello che mi spinge a continuare ad usare i vinili.
Spiega meglio.
La mia non è una battaglia ideologica, non sono di quelli che per forza bisogna usare i vinili sennò si è dei traditori. Non mi interessa cosa gli altri fanno o non fanno, anzi, se è per questo apprezzo anche chi riesce a fare un uso creativo della tecnologia. Peccato che ne senta pochi, che ci riescono. Tornando a me: io so che mi esprimo meglio usando i vinili. Punto. Questa è la cosa che conta. Da quando poi è arrivato il DB4 della Allen & Heath, un mixer fantastico, rivoluzionario, posso fare coi vinili praticamente tutto quello che potrei fare con Traktor, coi looper, con le varie macchinette esterne – tutto questo continuando ad usare i miei adorati vinili, adorati perché sono parte di me, della mia storia, col loro odore, con la loro consistenza fisica, il loro peso, la fatica che posso aver fatto per trovarli e comprarli, o anche solo per trasportarli. Questa è la mia storia. E da essa non voglio staccarmi. Mi capita di ricevere molte tracce in digitale, ovviamente; se mi piacciono, aspetto che escano in vinile per comprarle e suonarle. So che in questo modo mi precludo molto, spesso non riesco così a suonare certe cose in anteprima pur avendole e conoscendole, la gente mi dà del matto. Beh, preferisco aspettare. Lo diceva anche Oscar Wilde, no? “L’attesa del piacere è essa stessa un piacere”. Verissimo. Con l’ansia di velocità, di comprimere i tempi, di anticiparli, ci si è dimenticati di questa cosa che invece è assolutamente fondamentale. Poi ok, diciamolo anche che con Traktor è facile bluffare, e questo non mi piace. Per niente. Bisogna avere la capacità di riconoscere quando c’è il bluff, non va persa. Non andrebbe persa. Sai, tutto questo ragionamento arriva alla fine di un periodo di profonda riflessione. Un periodo iniziato, vedi le coincidenze, la prima volta che ci siamo incontrati per un’intervista io e te, qualche anno fa; periodo che ora è terminato, col risultato che queste mie convinzioni sono ancora più forti e profonde, sono l’approdo di un lungo viaggio mentale in cui mi sono messo in discussione più e più volte. La conclusione definitiva è stata ed è che io devo fare quello che so fare e continuare a farlo. Punto. Ci credo molto più di prima, dopo questa fase di pensamenti e ripensamenti in cui, tra l’altro, ho preso coscienza di molte cose su cui prima sorvolavo.
Tipo?
Quella più importante è che la gente, in un club, si deve divertire. Il concetto più profondo del party: qualcosa che, a mio modo di vedere, andrebbe a suo modo difeso dall’Unesco. E’ il divertimento della gente il cuore di tutto, non l’esibizione di un artista X e la sua autocelebrazione. Non comunicazione autoreferenziale di una star che comunica se stessa, ma uno scambio continuo tra dj e pubblico. Io sono nato e cresciuto con questo mood. E ogni volta che si deborda da questo mood, la mia impressione è che ci sia qualcosa che non vada: il dj/producer sale su un palco per esporre un suo prodotto, per esporre se stesso, e quindi non si mette in gioco completamente.
Però crea per bene il suo brand.
Perfetto. Il che significa che siam tutti sotto una macina che sta schiacciando tutto e riducendo in poltiglia quello che il dj rappresenta come appeal artistico e creativo. Perché ricordiamoci, il dj usa materiali sonori di terze persone, materiale di cui è creativamente autore – durante un dj set – al massimo all’1%. Ecco che allora la sua dignità artistica è per metà legata alla selezione dei pezzi, per l’altra metà al mixaggio – non dovrebbero entrare in campo altri aspetti nello stabilire il valore di un dj, solo in questo modo per me l’equazione è perfetta.
Solo così.
Damir, io vorrei sentire della musica che, quando ascolto i miei colleghi, mi faccia venire voglia di ballare, ma tanta. O anche di sedermi e ascoltare, me per sentire cose che mi aprano la testa in due e mi facciano correre a casa con l’urgenza smodata di accendere il computer e capire cosa abbiano fatto e suonato. Succede raramente, però. Di produzioni e serate ce ne sono in quantità ormai enormi, però quello che manca veramente è uno zoccolo duro della critica. Si è squagliato come neve al sole. Non esistono più dei media che non dico dettino regole, ma sappiano mettere delle asticelle, sappiano educare a pretendere degli standard qualitativi.
Le regole no, dai; anche perché se ti metti a dettare delle regole vuol dire che stai provando a costruire dei brand, se vogliamo continuare il discorso che si faceva poco fa…
Ci sono dei conflitti d’interesse clamorosi oggi, vedi Native Instruments. Probabilmente nemmeno loro si rendono conto del mostro che hanno creato, la situazione gli è sfuggita di mano. Che ti vende lo strumento per creare musica (in questo caso, il software) sia anche quello che ti dà la possibilità di distribuirlo, di suonarlo e di copiarlo è insano. Ecco, questo è un esempio perfetto di come l’evoluzione tecnologica – che di per sé è una cosa fantastica, io ne sono innamorato – possa diventare pericolosissima. Parliamo di creatività? Traktor sembra una cosa fantastica, ma se ascolti bene rende molto omologati nel suono i set. Nel rock, se tu suoni una Stratocaster viene fuori un suono, se suoni una Les Paul un altro, è così e sempre sarà così. Lo strumento insomma determina lo stile. Non credo che la musica elettronica sfugga a questa regola. Prendiamo invece Ableton Live: ci sono persone che ne sanno fare un uso incredibile, penso a Pier Bucci, uno che grazie a Live riesce a costruire quello che tecnicamente è un dj set aggiungendoci un elemento di improvvisazione che è quasi jazz. Questo sì che è gran cosa, così va bene. Ma quando la tecnologia serve per avvallare un bluff, e Live spesso aiuta in tal senso, ecco, mi dà molto fastidio. E quel è l’unico rimedio contro tutto ciò? Che la gente si sgami. Che si faccia più smaliziata e più in grado di riconoscere ciò che vale da ciò che fumo.
Succederà?
Sì. Se non altro perché oggi la tecnologia è molto più accessibile. Ableton Live, bene o male, ormai ce l’hanno tutti, anche quelli che non fanno i dj di professione – chi originale, chi crackato; quindi bene o male sarà sempre più facile che si capisca chi fa un uso creativo del software e chi no. Quello che invece mi preoccupa e mi scoraggia è il metro di giudizio del valore musicale. E’ sempre più in pericolo, messo in ombra dall’ansia che hanno tutti di parlare della musica “giusta”. Vuoi un esempio? Oggi mi scoraggia molto sentire all’improvviso che tutti dicono che la musica dubstep è fighissima, perché sento che quasi tutti lo fanno non perché questa musica la conoscano e apprezzino veramente, ma solo perché fa figo. Senti parlare di dubstep gente che, fino a cinque secondi fa, si muoveva come Villalobos e aveva il suo stesso taglio di capelli. Questo meccanismo di omologazione continua, che tocca anche stili musicali che sarebbero alternativi ed underground, mi spaventa. Un meccanismo che si sta esercitando sulle pelle della musica, invadendo il suo altare – un altare a cui invece si dovrebbe arrivare inginocchiati, a capo chino, col massimo dell’umiltà, con rispetto sacrale, e non certo con la voglia di sfruttarla per far vedere il proprio tasso di figaggine. Stiamo perdendo di vista i valori fondamentali dell’arte.
Non credo che sia un caso che molti padri nobili della dubstep, che so un Kode9, uno Skream o uno Scuba, ormai di dubstep non ne facciano più. Devono essere ben consci dei rischi dell’omologazione.
Cosa c’è di più bello e forte dell’eclettismo, per un dj? Dovrebbe essere il suo valore di riferimento assoluto!
Per un sacco di anni, fare dei set eclettici era da sfigati.
Eri sfigato sì, per il sistema: perché non stavi dentro al brand. Ma non è un problema per me, non più: io voglio essere un artigiano. Voglio essere il ciabattino che inchioda il tacco col chiodino. Preferisco essere questo, piuttosto che imbarcarmi in una guerra che perderei sicuramente, visto che non ho le armi, né la cattiveria, né la grinta di un ventenne. Ho figli, ho famiglia, ho mille interessi.
Non ti interessa più fare le doppie e le triple…
Non mi interessa, anche perché quello è stato il primo degli sbagli. Lo dico chiaro e forte. Provo a darmi una giustificazione: vivevamo in un momento storico in cui bastava aprire le porte di un club e la gente arrivava a frotte, non c’era nemmeno bisogno dei PR. Tutto si trasformava in business facile per tutti. Io non ho mai impoverito nessuno. Non so se si può dire la stessa cosa oggi, nel caso di alcuni artisti ed alcune serate.
Eh.
Soprattutto in un contesto in cui il mio paese viene trattato come un posto di imbecilli, gente buona sola per allungare solo dei cachet assurdi all’artista e al suo management. Siamo il posto da cui ottenere economicamente tantissimo dando, artisticamente, quasi nulla in cambio: ce ne rendiamo conto? Vogliamo cominciare a farci delle domande? Vogliamo chiederci perché certi artisti cachet di un certo tipo li ottengono solo in Italia? Soprattutto, vogliamo capire perché se suonano a Berlino o a Londra fanno dei set meravigliosi e qua invece delle cose noiose e prevedibili, set davvero di m***a? Che poi sai, questo è un film che io già visto…
…negli anni ’90, con gli americani pagati a peso d’oro.
Sì, oggi è così e volendo anche peggio. Il pubblico italiano è diventato sempre più carne da macello. La situazione è peggiorata, perché è peggiorata l’informazione musicale, come già prima accennavamo. Le generazioni che sono cresciute negli anni ’70 e ’80, e anche in parte dei ’90, hanno ancora quel tipo di approccio che deriva da un certo tipo di cultura di fruizione ed informazione della musica: lettura di giornali, un certo tipo di radio, l’ascolto condiviso ed approfondito di dischi. Io a casa ho ancora pile infinite di vecchi giornali musicali a casa, e non ho ancora l’intenzione di buttarli! Questa è la vera ricchezza, non avere diciottomila effetti su un pulsante.
O diciottomila tracce nell’hard disk.
Ecco, qua mi prenderò delle palate di m***a: per me, il vero dj inizia la sua serata ancora a casa, quando sceglie i dischi che mette nella sua borsa. Quali novità portarsi dietro, quali grandi classici, quali tracce buone. In questo modo succede che ti ritrovi in mezzo alla serata e ti maledici perché non hai portato “quel” disco? Perfetto! Fa parte del fascino del tutto. E ti fa capire che la serata perfetta non esiste, ma è qualcosa che devi e dovrai sempre inseguire.
Mentre invece se hai già tutto pronto a disposizione nel tuo hard disk…
Avere tutto non significa nulla. Avere tutto non ha mai creato nessun humus creativo, nessuna tensione artistica, nulla. Niente che ti faccia pensare consapevolmente “Io su questa serata c’ho riflettuto, c’è già un’idea di partenza dietro ai dischi che metterò”. Puoi immaginare quanto trascurassi questa cosa quando facevo le doppie e le triple… nei locali più sfigati mettevo direttamente su i dischi nuovi per sentire com’erano, visto che non avevo il tempo di ascoltarli a casa, figurati…
Ahia.
Capisci ora perché dico che bisognerebbe ridimensionare tutto. Esagerare fa male a te e alla musica. Conosco e capisco l’obiezione: “Bravo, tu ti sei fatto il tuo giro nella giostra e ora invece dici che bisogna fermare tutto: chi sei tu per dircelo?”. Risposta: proprio perché io il giro me lo sono fatto e so a cosa ti porta, penso di potermi permettere di dire che non vale la pena farlo! Bisogna riportare al centro di ogni discorso l’etica. Quante gente oggi si compra 1000 download del proprio pezzo su Beatport, così sale in classifica e si fa un nome? E non dovrei essere io a dirti che non va fatto, dovresti capirlo da solo, maledizione. E poi ancora: vogliamo parlare dei locali che continuano a bookare dei dj come se fossero le figurine di un album, tanto per raccogliere nomi senza nessun filo logico e senza nessuna direzione artistica? E, a proposito di direzione artistica, quei locali che delegano tutta la programmazione alle agenzie di booking? Ci rendiamo conto di quanto è insana ‘sta cosa? Ecco, io ho l’impressione che tedeschi ed inglesi non siano caduti in queste trappole. Faccio un esempio banale, nel campo della comunicazione: prendi il sito di Loco Dice, è davvero bello, soprattutto nella sua semplicità dà una forte idea di evoluzione e creatività, è evidente che dietro ad esso c’è un lavoro di persone che si sforzano di fare “quella” cosa in più. In Italia, invece, è tutto sclerotizzato, siamo tutti sclerotizzati. Riempiamo d’oro i dj, quando invece con anche solo una piccola parte di certi cachet d’oro si potrebbe dare molto, moltissimo ossigeno culturale al clubbing di casa nostra. Pensa solo a quanti laureati disoccupati del Dams o di Scienze della Comunicazione ci sono in giro, gente che potrebbe dare un bel contributo di idee nuove, fresche.
Ossigeno culturale, ok. Però forse negli anni ’90 era pure peggio, lì la dittatura dei “localari” era molto più forte di adesso, dai.
Sì, ma era tutto nuovo, tutto un terreno molto più vergine. Tra l’altro un merito me lo prendo: con la mia esperienza napoletana degli anni ’90 ho fatto esattamente questo, ho aperto una breccia nel fronte allora compatto dei “localari”. Oggi le cose sono molto meno libere: negli anni ’90 un rave fatto bene lo organizzavi in quindici giorni, oggi semplicemente non riusciresti ad organizzarlo mai, a meno che tu non voglia prenderti delle grandissime rogne. Berlino è un posto importante per tante ragioni artistiche, va bene, ma lo è prima di tutto perché ha il rapporto spazio/prezzo più conveniente d’Europa, con in più un’amministrazione pubblica illuminata. Lo vogliamo dire che il Berghain paga di canone annuale, al comune di Berlino, 1 euro all’anno? 1 euro! All’anno! Sono andati dalla municipalità, hanno proposto di riqualificare un edificio che era completamente abbandonato e se ne sono usciti con questo accordo, che sta facendo felici tutti, non solo i gestori del club ma anche la città stessa, visto l’enorme indotto che ha generato negli anni. E in Italia che facciamo? Abbiamo pure i fondi europei… peccato però che non li usiamo, con l’unica eccezione della Puglia.
Disastro.
Io ora parlo di ciò che non va. Di ciò che è positivo, nella club culture, ho parlato in tutta la mia vita precedente: di quanto la house valga tanto quanto la musica rock, di quanto il clubbing sia una vera e propria cultura con tutte le dignità possibili che una cultura ha… Bene, ora basta. Sono un vecchietto, e i vecchietti borbottano. Il mio ruolo ora è borbottare. Ma borbotto con la consapevolezza e la convinzione che in Italia abbiamo delle potenzialità ancora adesso enormi; il problema è che sono sparpagliate, disorganizzate, l’erba buona è sparsa in mezzo a un mare di erba cattiva. E da dove si parte per risolvere il problema? L’unico modo per iniziare a risolverlo è una presa di coscienza. Una presa di coscienza vera, non retorica. Perché nell’industrializzazione dei prodotti culturali andrai a finire sempre e comunque, è inevitabile, ma se ci finisci armato di una consistente consapevolezza culturale saprai fare le mosse giuste per te e per la cultura che ami. Peccato che la consapevolezza culturale sia sempre l’ultimo aspetto a cui si dà credito ed attenzione, qua da noi…
Domanda finale: mi raccontavi che hai un figlio che fa anch’egli il dj. Dovessi scegliere un dj da fargli sentire, a mo’ di esempio illuminato?
Il primo nome che mi viene in mente è Gilles Peterson. Per me, lui è una specie di Wikipedia umana della musica. E’ un peccato che, come succede spesso fra gli inglesi, non si sia mai preoccupato di crescere tecnicamente: in lui come in altri è una scelta precisa, come a dire che la selezione resta più importante del mixaggio – però è una scelta che non condivido. E allora il nome che faccio è Andy Weatherall: forse meno eclettico – almeno un po’ – ma bravo, bravissimo. Tra l’altro, uno che poteva diventare ricchissimo e famosissimo, se avesse cavalcato il sistema e se avesse lavorato sul brand di se stesso; invece ha fatto l’esatto contrario. Un grande. Un esempio.
Leggi l'articolo originale










